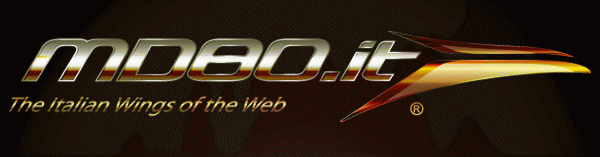In occasione dell’imminente quarantesimo anniversario dello sbarco umano sulla Luna, pubblichiamo quanto Luca Guidoni, figli di Umberto Guidoni, ci ha gentilmente concesso:
“Esattamente 40 anni fa, il 20 Luglio 1969 alle ore 22:17 ora italiana, Neil Armstrong ed Edwin “Buzz” Aldrin divennero i primi uomini a camminare sulla Luna, i primi uomini a metter piede su un corpo celeste diverso dalla Terra. Ancora oggi le missioni Apollo sono viste come l’epoca d’oro dell’esplorazione spaziale, il culmine del successo della tecnologia e dello sforzo umano, tanto che si parla del 2020 come la data del ritorno dell’uomo sulla Luna. Cosa ha significato questo storico evento e che senso ha continuare l’esplorazione spaziale?
Sicuramente il programma Apollo rappresenta il raggiungimento di un obiettivo inseguito da millenni, ma ancor di più dimostra come la tecnologia e lo sforzo collettivo ci portino a poter realizzare imprese ai limiti della fantascienza. Non bisogna scordare infatti che il successo del programma è dovuto al lavoro di centinaia di migliaia di persone (dal 1966 al 1967 vi furono impiegati in 420.000) integrate in un sistema estremamente complesso ed organizzato di competenze. Solamente in questo modo si è riusciti a compiere i grandi avvenimenti che oggi conosciamo.
C’era una motivazione politica dietro tutto questo entusiasmo? Sicuramente. La guerra fredda era nel suo pieno svolgimento e l’ordine imperativo era quello di battere l’Unione Sovietica in una corsa alla tecnologia orientata principalmente verso lo spazio, campo nel quale i russi avevano fino a quel momento un netto vantaggio. Questa competizione politica sicuramente è servita da incentivo allo sviluppo del programma Apollo, ha determinato la tipologia delle missioni sulla Luna, e in un certo senso ha anche segnato la fine dell’esplorazione umana del nostro satellite. La contrapposizione fra blocchi fece si che si puntò principalmente a sviluppare missioni mirate a portare gli astronauti sulla Luna nel modo più veloce possibile, impedendo così lo sviluppo, sia dal punto di vista economico che della sicurezza, di missioni sostenibili che avrebbero permesso un’approfondita esplorazione del nostro satellite. Non bisogna scordare che le probabilità di successo delle missioni lunari venivano date circa al 50%, un livello di rischio oggi non più tollerabile nelle missioni spaziali con equipaggio. Vi erano all’epoca tre tipologie di missioni possibili. La prima era di costruire un vettore capace di lanciare una capsula direttamente verso l’orbita lunare, e fu la strada intrapresa dai russi con il progetto N1, purtroppo senza successo. La strada più plausibile, e quella preferita dallo stesso Von Braun, era la costruzione di una stazione spaziale orbitante che avrebbe permesso l’assemblaggio in orbita, od il rifornimento, della navetta che poi avrebbe portato gli astronauti sulla Luna, ma questa soluzione avrebbe richiesto troppo tempo. Alla fine quindi si scelse la soluzione più rischiosa ma più veloce, il cosiddetto sistema “Rendez-Vous in Lunar Orbit” che però comportava una missione composta di numerose fasi complesse, ciascuna con i suoi rischi. Un problema in anche una sola di queste avrebbe portato al fallimento della missione, e in alcune fasi critiche come la ripartenza dal suolo lunare, alla perdita dell’equipaggio. Questa scelta segnò probabilmente il destino del programma prima ancora del suo enorme successo, poiché non permetteva uno sviluppo sostenibile dell’esplorazione lunare: era troppo rischioso e troppo costoso per un utilizzo a lungo termine. Inizialmente erano previste 20 missioni lunari, ma la ultime 3 furono cancellate: i vettori Saturno V, già costruiti per le missioni si trovano ora uno al Johnson Space Center di Houston, uno al Kennedy Space Center in Florida ed uno allo Smithsonian. Alla fine quindi, qual è stato il punto di portare l’uomo sulla Luna e di continuare l’esplorazione spaziale?
Molti, io per primo, portano come esempi dell’utilità delle missioni spaziali innovazioni tecniche che oggi sono possibili grazie alle tecnologie sperimentate durante il programma Apollo, come le padelle antiaderenti al Teflon, le celle a combustibile o i microprocessori. Non è però in queste piccole cose che si può quantificare l’importanza delle missioni Lunari, quanto invece nelle parole del presidente Kennedy durante il suo storico annuncio il 12 Settembre 1962: “noi scegliamo di andare sulla luna e fare tutte le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili. Perché qusta è una sfida che siamo disposti ad accettare, una sfida che non siamo disposti a posticipare, e che intendiamo vincere”. Credo sia questo il fulcro del significato dello sbarco sulla Luna, che riassume un po’ la forza dell’atteggiamento umano, capace di porsi un obiettivo ambizioso e raggiungerlo grazie allo sviluppo tecnologico ma soprattutto al lavoro di squadra. Questi obiettivi in particolare sono dettati principalmente dalla volontà di affrontare nuove sfide, e dalla possibilità di superarle grazie all’ingegno. C’è anche un aspetto tutto umano, che è quello di vedere la Terra da una nuova prospettiva. Le esperienze vissute nello spazio rendono le missioni ancora più straordinarie: vedere la terra proiettata sullo sfondo nero dello spazio è un effetto apprezzabile già in orbita terrestre ma deve essere stato ancora più evidente durante le missioni Apollo. Molti astronauti e cosmonauti sono stati profondamente cambiati dopo questa vista spettacolare, ad esempio Jim Lovell, comandante dell’Apollo 13, disse che fu molto turbato quando “si rese conto che poteva nascondere la terra con la sua mano”. Non a caso la foto della terra sullo sfondo nero dello spazio scattata dall’Apollo 17 è la più scaricata da internet.
Ancora oggi si va nello spazio per lo stesso motivo: per varcare i confini della nostra conoscienza ma soprattutto per osservare il “pianeta azzurro”, così come è stato battezzato dagli astronauti del programma Mercury da un’altra prospettiva, un punto di vista che ci aiuta, forse, a conoscere e ad amare il nostro pianeta.
Oggi però le missioni spaziali hanno preso un altro corso: dopo l’Apollo ci si rese conto che un solo paese, per quanto ricco e avanzato tecnologicamente, non avrebbe potuto continuare l’esplorazione del Sistema Solare da solo. La collaborazione internazionale è l’unico modo per poter portare avanti un obiettivo così ambizioso, ed è infatti su questo aspetto che ci si è concentrati dopo l’epica conquista della Luna. Dalla storica missione Apollo–Soyuz allo Space Shuttle sulla Mir al progetto della Stazione Spaziale Internazionale, le missioni spaziali che hanno seguito l’Apollo hanno dimostrato l’importanza del lavoro di squadra non più a livello nazionale ma a livello globale. Speriamo che in futuro, le nuove missioni lunari possano veramente rispecchiare il motto della targa lasciata da Armstrong ed Aldrin sul suolo lunare “Qui uomini dal pianeta terra hanno per la prima volta messo piede sulla Luna. Veniamo in pace per tutta l’umanità”.”
LUCA GUIDONI